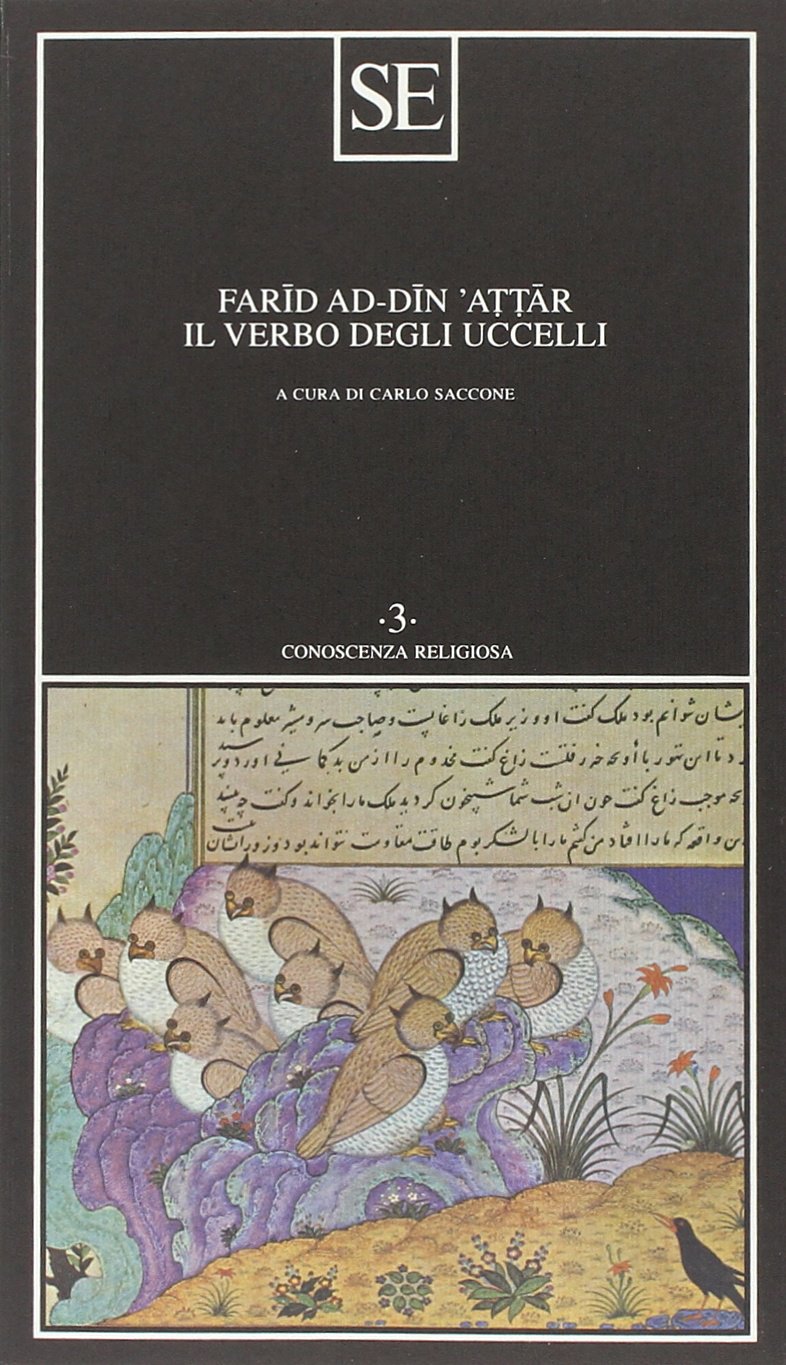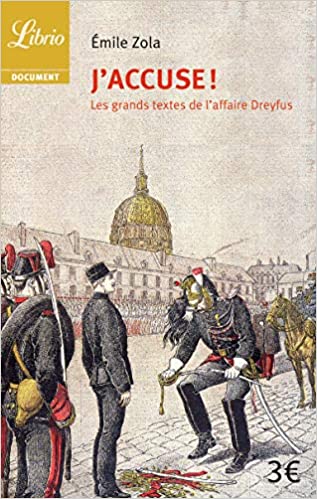La tua pratica artistica si realizza soprattutto nell’uso e nella condivisione dello spazio pubblico e intrattiene un forte rapporto con la socialità. Le tue opere si relazionano spesso coi modi in cui le persone vivono il territorio in cui abitano. Come ha influito il tempo della pandemia, del lockdown e del distanziamento sulla tua ricerca e visione del mondo?
Ad oggi non sono ancora in grado di definire esattamente quanto questo periodo ha inciso ed inciderà sulla mia ricerca futura. Ciò che però posso affermare è che sono stato profondamente coinvolto vivendo questo tempo con fasi a volte molto dure e complesse. Ho dovuto rimodulare completamente il mio iter di lavoro che prima della pandemia era fondamentalmente basato sui viaggi e sullo studio dei territori urbani e non, prevedendo una vera e propria condizione nel vivere in prima persona l’oggetto del racconto come per il progetto su Licola Mare in cui ho vissuto per un anno nel luogo oggetto della ricerca. Questo processo non era mirato ad un avvicinamento al reale, bensì ad una conoscenza diretta delle dinamiche per poterne definire lo scarto, l’artificio.
Il rapporto fra il tempo e lo spazio è l’argomento sul quale ho riflettuto più a lungo durante la pandemia. Le mie origini provinciali e pratiche hanno determinato una costruzione pragmatica della mia persona in cui il tempo è inteso come uno strumento prezioso da gestire con cura, mai da sprecare, e, nei momenti migliori, illudersi di dominarlo. Il concetto di spazio invece è una costruzione che devo al mio lavoro, i molti viaggi e l’indole nomade mi hanno dato una lettura dello spazio come possibilità e quindi, il poterlo esplorare e viverlo, è per me una fortuna. Non avendo più i miei riferimenti ho dovuto disegnare una nuova mappa su cui orientarmi ed ancorare un tempo sospeso.
ANTHROPOGENIC BRIDGE PROJECT, ADDIS ABEBA, 2020
“Anthropogenic Connection”, è l’ultimo progetto che hai sviluppato per il Museo Zoma in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Addis Abeba. Si tratta di un ponte a cui si accede da un lato tramite una scalinata, dall’altro con uno scivolo, qui coniughi l’aspetto performativo a quello sociale unendo due sponde. Quali altri progetti hai realizzato o concepito in un anno difficile come il 2020?
“Anthropogenic Connection” è stato la porta di ingresso alla pandemia, non ho potuto fare il mio ultimo viaggio ad Addis Abeba ed ho concluso la realizzazione dell’installazione a distanza grazie alla tecnologia. Il 2020 rimarrà per me l’anno dei progetti, ho lavorato moltissimo. Per il 90% si è trattato di puro esercizio muscolare, simile a quello svolto nelle palestre dei penitenziari. Una sorta di mantenimento. Ma superata questa fase, dettata dalla paura di scomparire e dall’incapacità di ammettere che non sarebbe stata una condizione a breve termine, ho iniziato ad immaginare diversamente.
Ora credo di aver pensato qualcosa che varrà la pena di montare e su cui sarà possibile discutere, ragionare. Si tratterà di un lavoro più intimo fatto, come sempre attraverso le tracce, un nuovo sguardo sul concetto di margine inteso come condizione mentale più che fisica. Condizione in grado di innescare un processo semantico alternativo al reale con codici estetici diversi da quelli che ho utilizzato fino ad ora. Al momento la descriverei come una ferita, uno squarcio su cui affacciarsi per sbirciare la voragine che è dentro ognuno di noi e che durante l’anno trascorso abbiamo dovuto affrontare.